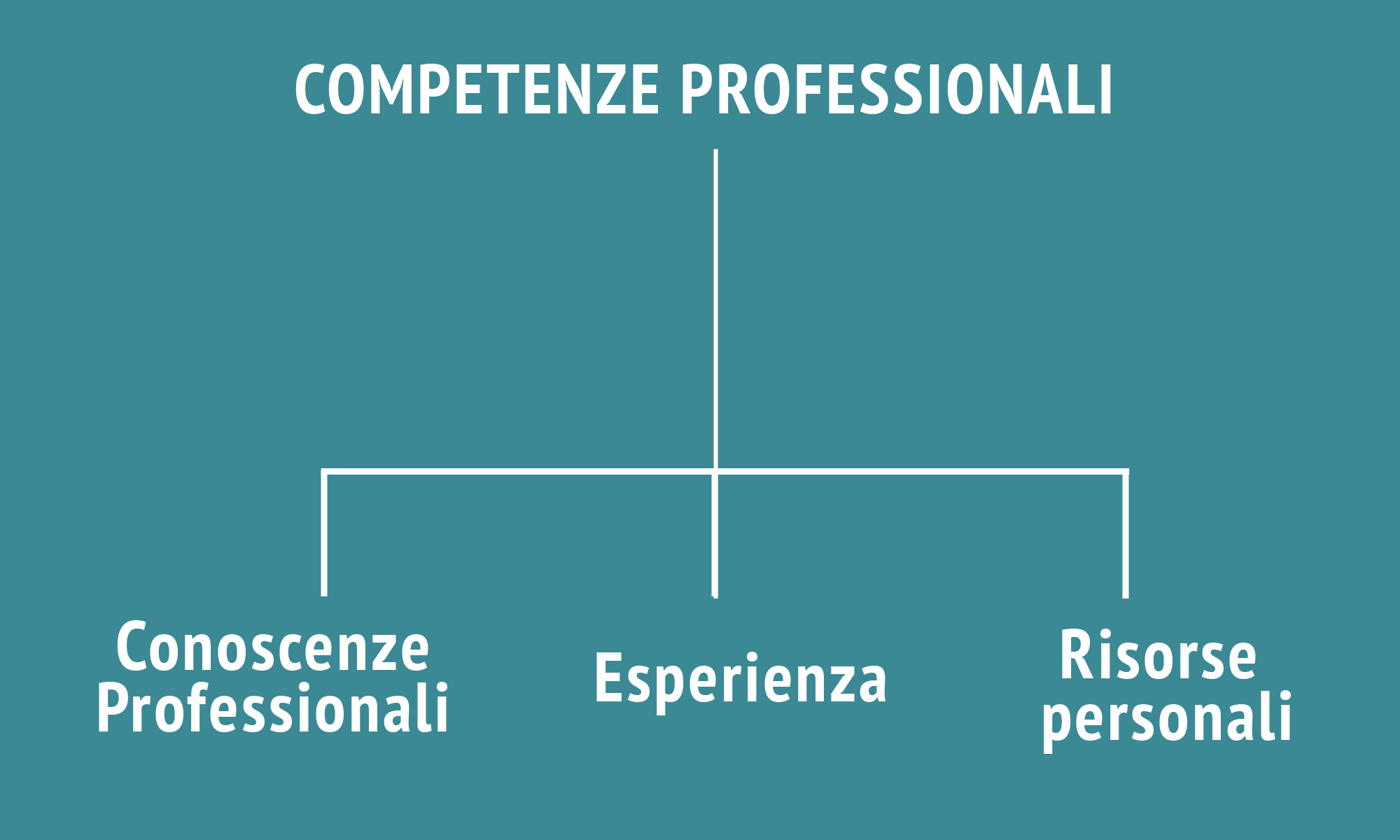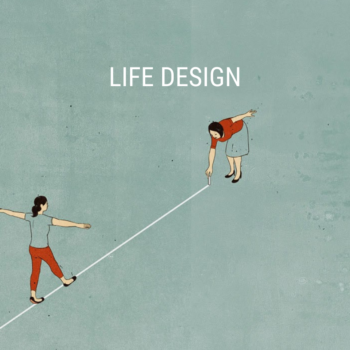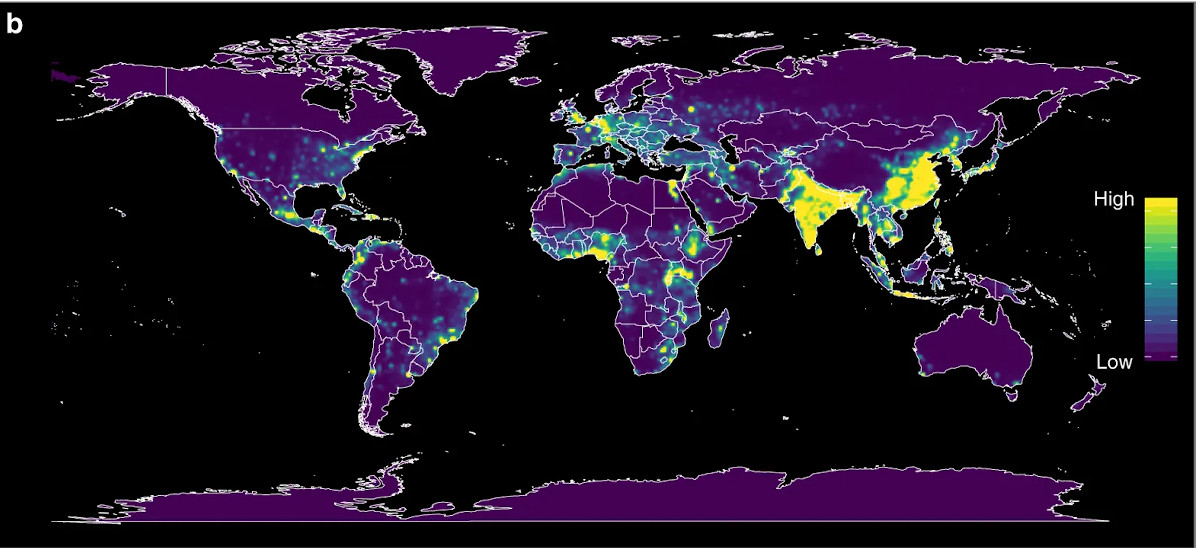di Nicola Grigion
Pubblicato da Che-Fare.com il 2 maggio 2020
Eccola la seconda fase. I cinquecentomila posti di lavoro volatilizzati nel solo mese di marzo e le stime sul PIL per il primo semestre 2020 ne impongono un’introduzione piena di dubbi e perplessità. Contemporaneamente, come se non vi fosse alternativa, ne segnano il carattere squisitamente commerciale.
La cosiddetta fase due, che già prima di iniziare rimanda all’attesa della terza, si presenta così con un difetto strutturale: si propone di traghettarci fuori dalla crisi, ma lo fa chiedendoci di scommettere su un mercato avaro di vita e compromesso dalla distanza. Rimuove, cioè, la realtà di una produzione che si nutre di flussi e relazioni, di comportamenti e cooperazione, strettamente legata alla vita in comune. Proprio per questo, però, questa fase due si presenta come terreno insidioso ma aperto, pieno di contraddizioni e quindi assolutamente fertile per chi vuole sperimentare innovazione. Un vero e proprio campo di tensione.
In fondo, chi si misura con l’innovazione sociale ha fin da ieri un doppio problema: da un lato quello di reinventare le forme con cui prendersi cura della comunità, dall’altro quello di affermare contemporaneamente, non in un momento successivo, l’egemonia di una nuova geografia del valore sociale, in cui la cura del comune abbandoni finalmente la posizione di grimaldello collaterale, o al massimo obiettivo finale sempre posticipato, per essere riconosciuta come asset centrale e condiviso di un nuovo modo di produrre valore. In altri termini, di affermare la cura del bene comune come terreno di convergenza esteso e abitato da una pluralità di attori e non come dimensione perennemente ingabbiata tra felicità e profitto, utile solo a reiterare l’esistente.
“Affermare la cura del bene comune come luogo abitato da una pluralità di attori e non come spazio ingabbiato tra felicità e profitto”
I punti su cui misurarci non sono pochi. C’è da riscrivere un nuovo alfabeto del welfare nel tempo in cui viene sancita per decreto una gerarchia tra bisogni accettabili e bisogni sacrificabili. C’è da reinventare una nuova geografia della vicinanza, della libertà di movimento e della prossimità, ora che il bios è imbrigliato dalla sua stessa sopravvivenza. Ci sono luoghi da ridisegnare e mondi da riconnettere. Ci sono da riprogrammare le agenzie educative e quelle della cura, i servizi di assistenza e quelli di utilità collettiva. Ma c’è anche da metabolizzare l’effetto del cosiddetto “distanziamento sociale” sulla mobilità, sulla concentrazione urbana, sulla co-abitazione degli spazi e sulla fiducia reciproca.
C’è, in sostanza, da ritessere la geometria della vita collettiva e ricostruire i margini dello spazio su cui si muove l’innovazione sociale. Quel lavoro sulla soglia della rottura che permette alla riproduzione sociale, alla cura del bene comune, di non essere sempre riconducibile a una relazione di valore di segno esclusivamente economico.
Tutt’altro che semplice. Perché se è vero che la pandemia ha aperto spazi assolutamente favorevoli, non possiamo non guardare ai registri su cui è calibrata la risposta. Anche in questa fase due, lenta solo in apparenza.
L’inganno del tempo
La rappresentazione del tempo, in questo senso, non gioca certo un aspetto secondario. Il frame della ripresa cauta e distanziata segue quello di una narrazione che, fino a ieri, ha sovrapposto l’immagine della città vuota a quella della città ferma. Un vero e proprio inganno. All’austerità di relazioni che abbiamo vissuto non è infatti corrisposta un’assenza di movimenti, di trame, di smottamenti. L’illusione, tuttavia, è durata ben poco. E’ evidente a tutti che in corso c’è una vera e propria metamorfosi urbana, sociale ed economica che non attende il tempo della ripartenza e non si sincronizza sulle sue fasi. Per comprenderne fino in fondo la radicalità e condizionarne eventualmente la direzione, non è consigliabile quindi rivolgere lo sguardo al futuro dimenticandoci del presente.
Da questo punto di vista l’innovazione sociale, intesa come processo ma anche come platea di attori che la rivendicano, cammina su un terreno piuttosto scivoloso. Il Terzo settore, l’associazionismo, l’impresa responsabile, i centri di ricerca, così come le agenzie e le istituzioni pubbliche, non sembrano esposte solo al pericolo di rimanere impantanate nella logica del tempo sospeso, cara a chi rinvia sempre a tempi migliori per poi riaffermare gli assetti precedenti, ma rischiano anche di farsi tentare da improbabili fughe in avanti, buone in fondo per essere comodamente riassorbite nel mantra retorico del cambiamento. La fagocitazione di questa domanda autentica di cambiamento è già in corso. E cadere nel tranello del “nuovismo” ideologico finirebbe per anestetizzare ogni ipotesi trasformativa. Perché celebrare il nuovo, talvolta, è il modo migliore per non misurarci mai con la realtà di un’innovazione capace di forzare i perimetri dell’esistente. A chi invece volesse volgere lo sguardo al presente non mancano i punti su cui far leva.
“Il mutualismo interpretato nel tempo del Covi19 ha allestito un nuovo piano condiviso della responsabilità sociale territoriale”
Il primo, ampiamente dibattuto, riguarda la vera e propria irruzione sulla scena pubblica di un neo-mutualismo che ha animato fin da subito il tempo della crisi. Ne avevamo francamente bisogno dopo un lungo periodo di rancori ed egoismi a dominare il discorso pubblico sulla composizione sociale. Sulla straordinarietà della sua ampiezza si è già detto molto. Da Roma a New York ha mobilitato milioni di persone coinvolte in attività di sostengo alla comunità, ma ha anche prodotto la più grande esperienza di solidarietà della storia, con oltre 650 milioni di euro raccolti, secondo quanto ha rilevato l’osservatorio di Italia No Profit.
A questa dimensione squisitamente quantitativa vanno tuttavia aggiunti alcuni elementi più marcatamente qualitativi. Perché il mutualismo interpretato nel tempo del Covi19 ha allestito un nuovo piano condiviso della responsabilità sociale territoriale, proponendo un nuovo livello di interazione, palese e dichiarato, che coinvolge una pluralità di soggetti – dalle istituzioni pubbliche ai singoli cittadini, dal terzo settore alle attività commerciali, oltre ad aziende e fondazioni – aprendo così a possibili trasformazioni.
Un volontariato liquido e maturo
Sul terreno del volontariato, ad esempio, ha proposto delle indicazioni tutt’altro che trascurabili. Ha messo in discussione definitivamente le sue traiettorie canoniche e la rigidità delle identità associative, ingaggiando una composizione di persone variegata, dalla provenienza diversa, capace di rivitalizzare un modo di prender parte alla collettività che forse aveva bisogno di essere liberato da troppe sovrastrutture e condizionamenti.
Di contro, ha affermato la presenza di una nuova realtà del volontariato che non si definisce tale, liquida, difficilmente inquadrabile in schemi conosciuti, meno propensa alla fidelizzazione, più incline al nomadismo associativo o, ancora più probabilmente, a sposare una dimensione di obiettivo più che di scopo.
Una platea che, tuttavia, si dimostra matura e rivendica l’ambizione di partecipare a processi collettivi di trasformazione della società più ampi, coinvolgenti, autentici. Il problema, d’altro canto, non è capire se e come chi si è impegnato in questa fase avrà la stessa disponibilità anche in avanti, cosa peraltro non semplice. E neppure eleggere i volontari e il volontariato a soggetto protagonista di questo processo di trasformazione.
Il punto è piuttosto legato al se e come siamo in grado fin da subito di nutrire e farci nutrire da questa spinta, per comprendere le indicazioni che offre, queste si, alla complessità dello stare insieme. La precipitazione delle vulnerabilità sanitarie, economiche e infrastrutturali di queste settimane, ha fatto il palio infatti con l’emersione di nuove convergenze intorno alla cura della comunità che, in una società che mette in fila una crisi dopo l’altra, non può essere relegata ad elemento secondario.
“Non si tratta di catturare la disponibilità di nuovi volontari, ma di farsi trasformare dalla ricchezza che questa vitalità ci ha consegnato”
Per capirci, non si tratta di catturare la disponibilità di nuovi volontari, di ringraziarne la bontà d’animo o, ancor peggio, di teorizzare la gratuità del lavoro di cura, ma di farsi trasformare dalla ricchezza che questa vitalità ci ha consegnato, assumendosi il rischio vero, concreto, del terreno della cura come nuova dimensione ricompositiva e dell’innovazione aperta come chiave strategica. Una prospettiva, questa, non circoscritta al mondo del Terzo Settore e all’associazionismo, ma estesa alla possibilità di reinventare interamente il welfare e la sua governance.
Una nuova porosità istituzionale
A questo proposito non può sfuggire come l’esperienza di questo tempo abbia anche rivelato, a tratti, le potenzialità di una nuova porosità istituzionale. In molte città la crisi ha aperto orizzonti possibili e variegate possibilità di intrecci. Non solo nella città di Milano dove Milano Aiuta o la scommessa di elaborare insieme ai cittadini la strategia di adattamento rappresentano certo una sperimentazione importante. Ma c’è una costellazione variegata di nuove alleanze locali che, in questa fase, sta riproponendo l’urgenza di trovare modelli di governance che sanciscano definitivamente la fine della dicotomia pubblico-privato. Un percorso, questo, altrimenti incompiuto.
Da un lato, infatti, rimane il problema di costruire una governance di processi, anche privati, capace di far propria una nuova dimensione di responsabilità pubblica, evitando che l’iniziativa privata, anche quando sociale, sia ripiegata sul’’interesse particolare e riproponga se stessa e la sua esistenza ,senza mai porsi il problema di farsi istituto del comune e andare oltre i confini della propria organizzazione.
Dall’altro, tuttavia, non sembra più rinviabile l’individuazione di forme di interazione tra pubblico e privato in grado di liberare le spinte innovative, senza imbrigliarle in schemi inutilmente rigidi, spesso frutto di esigenze organizzative e non solo dettati da esigenze normative.
Non solo gli appalti centrati sul ribasso da sostituire con co-progettazione di servizi, piattaforme e gare fondate sull’impatto, ma le stesse possibilità offerte dagli strumenti della co-programmazione e della co-progettazione hanno bisogno di essere riletti: da opzioni tecniche attivate su singole linee di intervento, a modalità di approccio strutturale nell’interpretazione del governo locale. Su questo terreno la crisi ha messo a nudo un bisogno impellente e alcune possibilità inedite. Ora si tratta di far diventare questo momento occasione per osare, senza attendere un dopo che tarda a venire.
Vi sono tuttavia alcune questioni che non sembrano trovare piena legittimità nel dibattito di questi giorni e che mi sembra quindi utile restituire all’ordine del discorso.
La rottura
La prima, riguarda il rapporto tutt’altro che indifferente tra innovazione sociale e regolazione della vita. Si tratta, forse, di uno dei terreni più problematici del presente. Tuttavia, o forse proprio per questo, sembra sempre affrontato in maniera disgiunta, come se fosse una questione separata, al più interessante in chiave valoriale o di etica del diritto. Ma per riscrivere il presente, per produrre cioè innovazione, è possibile abitare il tempo delle relazioni contingentate e disciplinate senza porsi il problema della rottura?
La domanda ha fino in fondo a che vedere con la natura dell’innovazione stessa e dei suoi processi. In primo luogo perché l’innovazione sociale, in quanto dinamica aperta, si nutre proprio della tessitura di relazioni, di un’intelligenza collettiva che ha bisogno di essere innescata, condivisa, non imbrigliata. In secondo luogo perché proprio l’innovazione sociale si muove permanentemente sul perimetro della rottura, sull’equilibrio di un rapporto di forza che coinvolge l’orizzonte definito e il suo possibile oltre.
Per scrivere una nuova toponomastica dell’esistente, una nuova economia della cura che vada oltre le maglie del profitto e delle sue regole di accesso alla ricchezza, non basta quindi sostituire allo stanco erogatore di welfare pubblico, una platea scalpitante di soggetti del Terzo settore.
Peraltro questi hanno in larga parte bisogno di uscire dall’ipocrisia auto-celebrativa che li vuole depositari di un valore intrinseco, indiscutibile, inattaccabile (basta pensare, da questo punto di vista, al piano della valorizzazione e della tutela dei lavoratori) e in fondo sembrano rivendicare il ruolo di stampella, tra i fallimenti dello stato e del mercato, che gli viene assegnato.
“Il nuovo welfare per definirsi innovativo non può che essere universale”
C’è invece da lavorare per articolare in forma aperta la semantica di un nuovo welfare che, per definirsi innovativo, non può che essere universale. In altre parole, è la possibilità di produrre un suo allargamento che qualifica un nuovo welfare possibile, non la natura di chi lo eroga. E questo è fino in fondo un terreno di rottura.
Perché con un sano realismo – questo si dovuto – è bene riconoscere che le potenzialità aperte nel tempo di questa pandemia non si stanno traducendo, per il momento, in risposte all’altezza. L’uscita dalla crisi, così come ci è stata proposta finora, parla tutt’altro che il linguaggio dell’universale e della trasformazione, al di là dei richiami all’unità nazionale e alla ricostruzione.
L’accesso stratificato alle misure di sostegno individuale, il carattere marcatamente segmentato delle iniziative per la ripresa economica, le gerarchie di genere e del lavoro riproposte come immutabili, l’introduzione, culturale prima ancora che giuridica, della deroga ai principi costituzionali come possibilità di risposta alla crisi, alludono invece a una reiterazione di processi di inclusione differenziale e condizionata alla ricchezza collettiva. E fare i conti con questa realtà non è per nulla un processo morbido .
Si tratta, in ogni caso, di un campo aperto. Ed è bene essere consapevoli che non agiamo in uno spazio neutrale. Le aree urbane, come quelle interne, sono a loro modo attraversate da una straordinaria ambivalenza che non è possibile ricondurre ad unità, né è possibile illudersi di appiattire.
Sono dimensioni in cui convivono l’eccezionale vissuto di biodiversità culturale, di solidarietà e di reciprocità di cui stiamo assaporando le potenzialità, ma anche di spazi dove sono incardinate le gerarchie della ricchezza e della cittadinanza, dove si annidano egoismi e rancori sociali, linee del potere e della marginalità. Non sarà quindi un’ecumenica attesa a salvarci. Semmai, abbiamo davanti un tortuoso processo di ricomposizione su cui lavorare. Perché non vi è innovazione sociale possibile senza il coraggio di agire su queste linee di frattura, di prender parte.
C’è quindi un urgente bisogno di uscire dal guscio delle certezze per fare i conti con la realtà, di abbandonare atteggiamenti auto-conservativi e scrollarsi di dosso quelli rivendicativi, ma anche ogni velleità tattica, machiavellica, per liberarsi definitivamente da quel riflesso incondizionato che porta sempre all’attesa di un’ora X in cui tutto sarà possibile.
Per farlo, abbiamo bisogno di mani sporche di errori, capaci di assumersi la responsabilità di un’innovazione sociale imperfetta ma praticata, non solo evocata. In altre parole, aperta.
“Costruire il presente e il futuro in un tempo unico. Solo in questo modo pratica e pensiero potranno trovare una sincronia utile”
Perché abitare l’incertezza non può essere una tattica buona solo per superare il guado, per riorganizzarsi e resistere, ma va assunta come terreno strategico e, paradossalmente, driver progettuale su cui costruire il presente e il futuro in un tempo unico: il qui ed ora. Solo in questo modo pratica e pensiero potranno trovare una sincronia utile.
Certo, il contesto è tutt’altro che prosperoso e rassicurante. D’altro canto servirebbero interventi strutturali, normativi e culturali fuori dal registro ordinario di un discorso che, ammantanto di cambiamento, ripropone le ricette di sempre. Ma questa non può più essere la scusa per rimanere immobili o occupare un ruolo ai margini. Assumere questa sfida come progettuale non può significare accontentarsi di un mero ruolo rivendicativo.
Perché il processo dell’innovazione sociale non può essere semplicemente incentivato, promosso, liberato. Va vissuto. E’ un divenire continuo da conquistare. Un motto felice, di parte, da giocare fino in fondo, a costo di mostrare tutti gli errori accumulati finora.